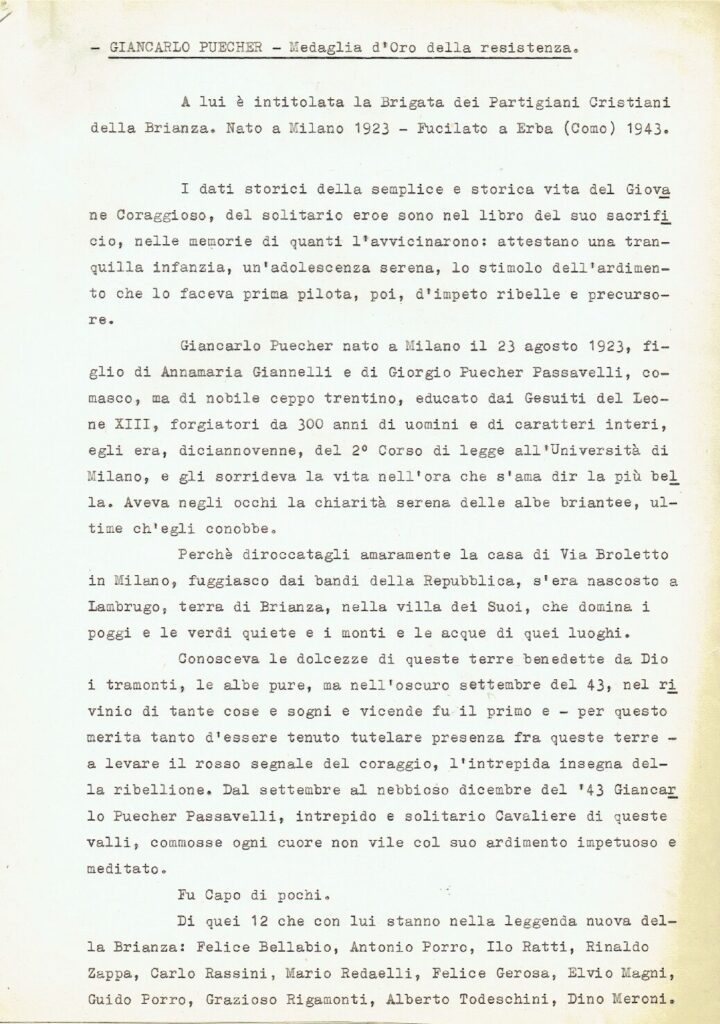Giancarlo Puecher nacque a Milano il 23 agosto 1923 da Giorgio e Anna Giannelli, primo di tre figli. Il padre, discendente da una famiglia aristocratica trentina, svolgeva nel capoluogo lombardo la professione di notaio. Attese agli studi ginnasiali al liceo Giuseppe Parini di Milano e, successivamente, si iscrisse all’Istituto Leone XIII dei padri gesuiti per completare i suoi studi superiori. Fu durante la sua permanenza in questa struttura che partecipò alle attività dell’associazione interna all’istituto. Conseguita la maturità classica e ottenuto il diploma, decise di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano. Particolarmente avvezzo alla pratica sportiva, eccelleva in diverse specialità come il ciclismo, il nuoto e l’atletica leggera, ma nel corso dei suoi anni giovanili ebbe particolare predilezione verso le competizioni sciistiche.
Abbandonati temporaneamente gli studi per arruolarsi nella Regia Aeronautica, si iscrisse al corso per allievi ufficiali e, ottenuto il brevetto di aviatore, decise di arruolarsi come pilota volontario. La sua domanda venne accettata ma, prima di riuscire a prendere regolare servizio, nel luglio del 1943 P. dovette assistere alla caduta del regime e alla conseguente firma dell’armistizio dell’8 settembre.
Sfollato, insieme alla famiglia, alla villa di proprietà a Lambrugo, ben presto decise di avvicinarsi alla cellula di antifascisti attivi in Brianza. Intessuti i primi contatti, fu tra i pochi ad attivarsi nel tentativo di predisporre una Guardia nazionale formata da militari sbandati e volontari, che si opponesse all’occupazione tedesca. Fu in questi giorni che decise di chiedere consiglio al parroco di Lambrugo, don Edoardo Arrigoni, che lo spinse a raggiungere il nucleo di resistenti che andava formandosi intorno al parroco di Ponte Lambro, don Giovanni Strada.
Fu dunque per iniziativa di P., del suo compagno di azione Franco Fucci, ufficiale sbandato del 5° alpini, e di don Strada, che nei giorni appena successivi alla ratifica dell’armistizio si riunì un folto gruppo di volontari che si adoperò nella costituzione di una banda armata nella zona presso Monte Lambro. All’atto della sua scelta di inserirsi tra le fila della Resistenza, P. decise di stilare una lettera, datata 13 settembre, nella quale delineò i tratti della sua decisione di salire in montagna: già nelle prime righe egli confermò che «tutto ciò che feci, lo feci per il bene patrio. Dulce et decorum est pro patria mori». Vista la consapevolezza del rischio assunto da P., il documento si configura come un vero e proprio testamento spirituale.
Nei primi giorni di formazione del gruppo le operazioni si limitarono a una continua e prudente ricerca di armi e munizioni per permettere agli uomini di avviare una efficace guerriglia contro le forze nazifasciste presenti nel territorio. Col passare dei giorni fervente divenne anche l’attività volta a rifornire i nuclei partigiani che andavano formandosi nelle zone circostanti. Diverse furono le requisizioni di mezzi di trasporto e di carburante, strumenti utili per mantenere i contatti tra le diverse bande e coordinare le azioni di sabotaggio.
Il 12 novembre 1943, dopo essersi recato nella casa dell’ex consigliere nazionale della Camera dei fasci e delle corporazioni Alessandro Gorini a Canzo alla ricerca di aiuti e finanziamenti per il movimento partigiano, P., insieme a Fucci, si trovò a percorrere, oltre l’orario di coprifuoco, la via che conduceva alla sua casa di Lambrugo. Furono fermati da una pattuglia di militi della Rsi nei pressi di Lezza e, fatti scendere dalla bicicletta, fu intimato loro di seguire il manipolo di uomini verso la caserma di Erba. I due uomini, pur accettando l’ordine, dovettero ben presto accorgersi della gravità della situazione che andava delineandosi. Vista la loro attività, infatti, si trovavano in quel momento armati, muniti di esplosivo e di alcuni manifesti di propaganda antifascista. Per questo motivo, mentre seguivano il drappello di militari, decisero di tentare la fuga ma, scoperti, dovettero ingaggiare uno scontro a fuoco nel quale Fucci venne ferito mentre P., pur non essendo stato colpito, dopo essersi riuscito a liberare della sua arma senza essere visto, venne catturato e duramente percosso.
Posto in stato di arresto, P. venne condotto in caserma e sottoposto a un durissimo interrogatorio per indurlo a svelare la sua identità e ricavare informazioni utili a individuare la sacca di Resistenza presente nel territorio. Pur dovendo subire numerose sevizie, non rivelò nulla di utile agli aguzzini e rifiutò sdegnosamente qualsiasi tentativo di trattativa. Visto il suo ostinato silenzio, per indurlo a parlare venne prelevato il padre dalla sua abitazione di Lambrugo e condotto anche lui nel carcere San Donnino di Como. A nulla valsero però intimidazioni, lusinghe e minacce: durante il periodo di detenzione P. rimase fermo nella sua volontà di non tradire i suoi compagni.
Il 21 dicembre successivo fu fatta circolare la notizia dell’uccisione in Brianza dello squadrista di Erba Germano Frigerio che, mentre si recava a Milano per il funerale di Aldo Resega, fu freddato in strada da alcuni uomini rimasti ignoti. Il prefetto di Como Franco Scassellati, avuti ragguagli sull’episodio, decise di adoperarsi affinché l’atto non restasse impunito. Convocati dunque alcuni ufficiali della Rsi, diede loro mandato di riunirsi in un Tribunale militare speciale, presieduto dal colonnello Biagio Sallusti, per esprimere giudizio e ordire la rappresaglia necessaria per il mantenimento dell’ordine.
Vittima designata per il processo fu proprio P., al quale venne ben presto presentata l’istanza per la sentenza che il tribunale istituito avrebbe dovuto solamente sottoscrivere. A nulla valsero le rimostranze del difensore d’ufficio avv. Gianfranco Beltramini che, venuto a conoscenza della volontà della Questura di condannare a morte un gruppo di antifascisti locali che nulla potevano avere a che fare con l’uccisione dello squadrista, tentò di far dichiarare il processo ineseguibile visto la totale estraneità degli imputati. Condotto nell’ufficio del podestà nel municipio di Erba, P. non ebbe modo di difendersi e la sentenza venne confermata senza indugiare ulteriormente. Nel documento redatto per la sua condanna, si confermò per l’imputato l’accusa di «avere in territorio di Erba dopo l’8 settembre del ’43 promosso, organizzato e comandato una banda armata di sbandati dell’ex esercito allo scopo di sovvertire le istituzioni dello Stato e per commettere furti, rapine e atti terroristici». A questa generale motivazione si aggiunse: «per essersi impossessato mediante violenza ed uso di armi, insieme ad altri partigiani rimasti sconosciuti in una sera imprecisata del settembre 1943 in Erba, di alcuni bidoni di benzina depositati presso l’Albergo Crotto Rosa».
Al cappellano della formazione fascista al quale venne dato mandato di assisterlo, don Fiorentino Bastaroli, P. decise di consegnare le sue ultime volontà. In una lettera indirizzata alla famiglia scrisse: «Muoio per la mia Patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serva ai miei fratelli e compagni. Iddio mi ha voluto, accetto con rassegnazione il Suo Volere». Spiegando poi i motivi della sua scelta di unirsi alle formazioni partigiane ebbe modo di sottolineare il suo amore patriottico, manifestando il desiderio di non vederla ancora sotto il giogo tedesco: «L’amavo troppo la mia Patria! Non la tradite, e voi tutti, giovani d’Italia, seguite la mia via ed avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale. Perdono a coloro che mi giustiziano perché non sanno quello che fanno e non pensano che l’uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia».
P. venne condotto lo stesso 21 dicembre davanti alle mura del cimitero nuovo di Erba per l’esecuzione della sentenza di morte. Posto innanzi al plotone, chiese e ottenne che gli fossero slegate le mani e, prima di essere raggiunto dalla raffica di mitragliatrice, riuscì a gridare «Viva l’Italia!».
Il 26 ottobre 1945 il luogotenente generale del regno Umberto di Savoia decretò per P. la medaglia d’oro al valor militare alla memoria con la qualifica di comandante di gruppo partigiani, gruppo «Lambrugo», con la seguente motivazione: «Patriota di elevatissime idealità, scelse con ferma coscienza dal primo istante la via del rischio e del sacrificio. Subito dopo l’armistizio attrasse, organizzò, guidò un gruppo di giovani iniziando nella zona di Lambrugo, Ponte Lambro, il movimento clandestino di liberazione ed offrendo la sua casa come luogo di convegno. Con lo esempio personale fortificò nei compagni la fede nell’azione che essi dovevano più tardi proseguire in suo nome. Presente e primo in ogni impresa gettò nella lotta tutto se stesso prodigandovi le risorse di una mente evoluta e di un forte fisico, ed associando all’audacia un particolare spirito cavalleresco. Braccato dagli sgherri fascisti, insidiata la sicurezza della sua famiglia, non desistette. Incarcerato con numerosi suoi compagni e poi col padre, d’accordo con questi rifiutò la evasione per non allontanarsi dai compagni di fede e di sventura. Condannato a morte dopo sommario processo, volle essere animatore sino all’estremo, lasciando scritti di ardente amor patrio e di incitamento alla continuazione dell’opera intrapresa. Trasportato al luogo del supplizio, chiese di conoscere il nome dei suoi esecutori per ricordarli nelle preghiere di quell’aldilà in cui fermamente credeva, e tutti i presenti abbracciò e baciò, ad ognuno lasciando in memoria un oggetto personale, pronunciando parole nobilissime di perdono e rincuorando coloro che esitavano di fronte al delitto da compiere. Cadde a vent’anni da apostolo e da soldato, sublimando nella morte la multiforme e consapevole spiritualità che aveva contraddistinto la sua azione partigiana. Como-Erba, 9 settembre – 23 dicembre 1943».